Durante il lungo Impero asburgico Trieste accolse molti laureati a Vienna, Graz e Innsbruck stimolando così una vivacità culturale che nel resto d’Italia era ancora piuttosto arretrata.
Nei primi anni del Novecento alcuni intellettuali aggiornati su libri e riviste in lingua tedesca iniziarono a discutere sulle nuove teorie psicanalitiche di Sigmund Freud e radunandosi in circoli privati iniziarono a valutarle con grande interesse. L’importatore delle rivoluzionarie dottrine fu il celebre concittadino Edoardo Weiss, nato il 21 settembre 1889 da un’agiata famiglia ebraica di Trieste.
 Dopo aver concluso gli studi liceali e fortemente attratto dalle teorie di Freud, si trasferì a Vienna per conseguire la laurea in medicina e la specializzazione in psichiatria.
Dopo aver concluso gli studi liceali e fortemente attratto dalle teorie di Freud, si trasferì a Vienna per conseguire la laurea in medicina e la specializzazione in psichiatria.
Allievo del dott. Paul Federn, Weiss conobbe lo stesso Freud, con il quale intraprese in seguito una lunga corrispondenza epistolare.
A 29 anni venne assunto dall’ospedale psichiatrico di Trieste dove si dedicò alle alterazioni psichiche e alle dinamiche delle psicosi, da lui definite “malattie dell’io”.
I nuovi metodi del dott. Weiss furono inizialmente accolti con una certa diffidenza ma alcuni famosi scrittori triestini vollero sottoporsi, con discutibili esiti, alle sue cure innovative contribuendo a una loro certa notorietà. Tra questi si menzionano il poeta Umberto Saba, il cui discusso libro Ernesto fu un vero coming-out ante-litteram, lo scrittore Guido Voghera (1884-1959) e il grande romanziere Italo Svevo, che seppure con spirito distaccato e ironico ne trasse ispirazione per la trama de La coscienza di Zeno.
In un articolo del Piccolo illustrato (datato 29/11/1980) Giorgio Voghera (1918-1999) figlio dell’Anonimo triestino, autore de Il segreto, analizzò i reconditi motivi d’interesse dei nostri concittadini per le complesse dinamiche interiori scrivendo con sottile arguzia:
“Non si trattava di neurotici comuni, come lo sono quasi tutti gli uomini su questa terra, ma di neurotici gravemente tormentati dalla loro nevrosi. Era, in altre parole, gente che soffriva molto, che non riusciva a trovare pace e durevoli soddisfazioni in questa vita e non sperava d’altro canto in nessun’altra. La psicanalisi dava finalmente (o pretendeva di dare) un volto definito al loro male, ne indicava le cause, faceva balenare qualche vaga speranza di guarigione.”
Nel 1931 Edoardo Weiss abbandonò l’ospedale psichiatrico di Trieste per la sua opposizione al fascismo e trasferitosi a Roma iniziò, tra molte difficoltà, un’attività privata. Sostenuto da un gruppo di allievi entusiasti, ricostituì la Società psicanalitica italiana, precedentemente fondata da Marco Levi Bianchini ma rimasta solo un sodalizio nominale e fondò la Rivista italiana di Psicanalisi che ebbe però una vita brevissima per l’ostruzionismo del regime.
Nel 1939 dopo la promulgazioni delle leggi razziali, fu costretto a emigrare con la famiglia negli Stati Uniti.
Stabilitosi definitivamente a Chicago continuò a dedicarsi agli studi della psicosomatica, alle complesse strutture della mente umana fino a sondare il terribile fenomeno della disgregazione dell’io cercando sempre di ottenere risultati terapeutici in tempi più brevi di quelli previsti dal trattamento freudiano classico.
I “Principi di psicodinamica” del 1950 e “Struttura e dinamiche della mente umana” del 1960 furono le due principali opere teoriche scritte da Weiss nei 31 anni della sua permanenza in America.
Il 1° dicembre 1970 il grande pioniere dello spazio interiore dell’uomo concluse a Chicago la sua lunga vita dedicata allo studio e al lavoro.
Notizie tratte da un articolo di Anna Maria Accerboni sul “Piccolo illustrato”, Trieste, 29 novembre 1980
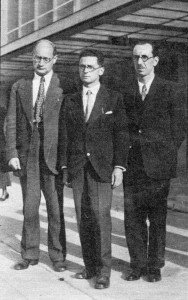

 Tra i molti personaggi vissuti a Trieste rimasti nella cronologia storia, vorremmo ricordare l’eccentrico e ricchissimo uomo d’affari Antonio Cassis Faraone. La sua antica e nobile famiglia, originaria dell’altopiano siriano di Hauran, nel corso del XV secolo si trasferì a Damasco acquisendo nel tempo un tal potere da essere soprannominata Pharaon, cioè “colui che ispira paura”. Lì nacquero i fratelli Giuseppe nel 1721 e Antonio nel 1745.
Tra i molti personaggi vissuti a Trieste rimasti nella cronologia storia, vorremmo ricordare l’eccentrico e ricchissimo uomo d’affari Antonio Cassis Faraone. La sua antica e nobile famiglia, originaria dell’altopiano siriano di Hauran, nel corso del XV secolo si trasferì a Damasco acquisendo nel tempo un tal potere da essere soprannominata Pharaon, cioè “colui che ispira paura”. Lì nacquero i fratelli Giuseppe nel 1721 e Antonio nel 1745.
 Con l’andar del tempo però le fortune di Cassis Faraone si ridussero progressivamente: alcune proprietà immobiliari furono vendute e una parte delle sue favolose collezioni finirono in mano dei più famosi antiquari londinesi e francesi. (*)
Con l’andar del tempo però le fortune di Cassis Faraone si ridussero progressivamente: alcune proprietà immobiliari furono vendute e una parte delle sue favolose collezioni finirono in mano dei più famosi antiquari londinesi e francesi. (*)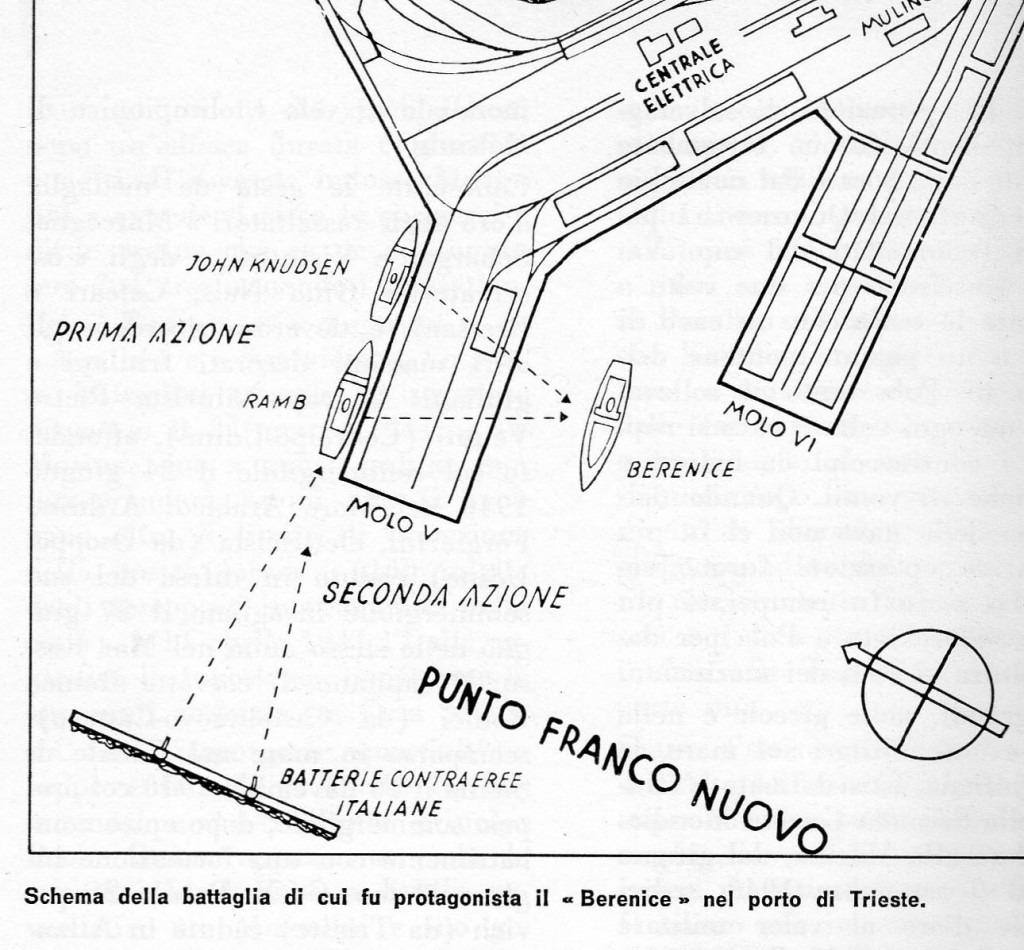

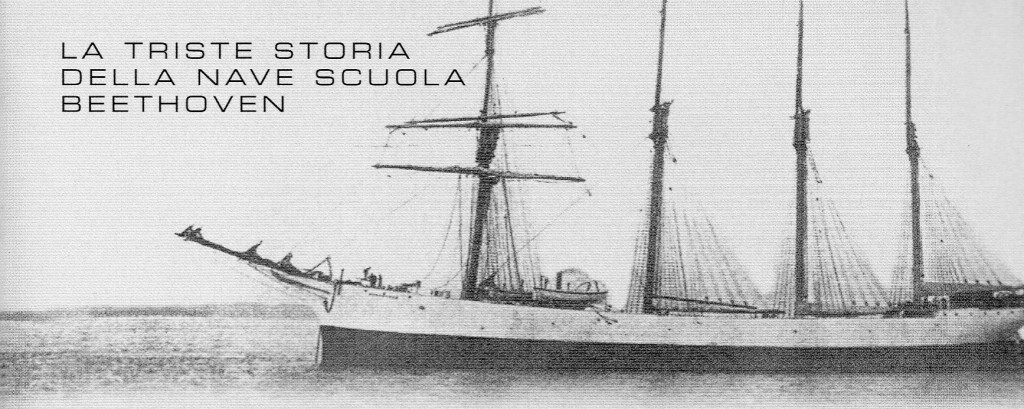
![936566_448478938576045_984901370_n[1]](https://quitrieste.it/wp-content/uploads/2013/07/936566_448478938576045_984901370_n11-200x300.jpg)