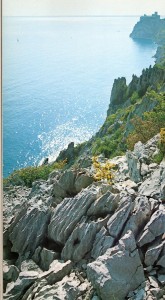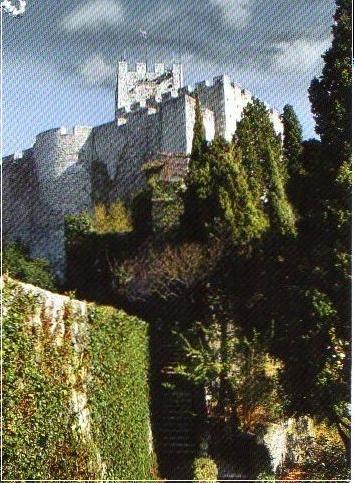A volte però l’ars gratia artis non compensa le fatiche perseguite con tanta passione né appaga gli animi più inquieti provocando sensi di inadeguatezza e frustrazione.
Vorremmo qui ricordare la triste storia di un artista talmente umile e modesto da essere schernito e infine abbandonato nella disperazione della sua breve, infelice vita.
Arturo Fittke nacque a Trieste il 16 dicembre 1873 da genitori nativi di Bredow (a Nord-est dell’attuale Germania, ma all’epoca territorio polacco). Svogliato studente della Scuola Superiore del Commercio, seguì le lezioni di Eugenio Scomparini, insegnante di disegno alle Scuole Industriali (e dal 1907 curatore del Museo Revoltella) scegliendo poi di iscriversi all’Accademia di Monaco, fucina di tutti gli artisti alla ricerca di un’identità autonoma rispetto alle correnti di moda a Parigi.
Ma a soli 23 anni Arturo fu costretto ad abbandonare gli studi per l’improvvisa morte del padre. Costretto al sostentamento della madre e della cognata, abbandonata da un fratello irresponsabile, ritornò a Trieste accettando un misero impiego alle Poste.
Oppresso dall’odiato lavoro, Arturo riservò alla pittura tutte le sue solitarie domeniche che trascorreva in mezzo alla natura riprodotta con colori vividi e luminosi. sfumature di colore.
Il suo carattere timido e modesto, la sua estrema sensibilità, forse “borderline” già in giovane età, lo isolarono però sempre di più dalle intraprendenti vite dei più fortunati colleghi artisti.
Di anno in anno Fittke sprofondò così in una debolezza di nervi accentuata da una salute instabile e da un globale “mobbing” ante litteram che lo condusse a manie psicotiche e persecutorie.
Durante un viaggio di ritorno dall’Austria, nei pressi di Divaccia, dopo l’ultima, tragica notte insonne, il suo cervello implose ben prima del proiettile che lo perforò.
L’incapacità di risolvere i suoi problemi esistenziali, la progressiva perdita della vista e forse l’infausta diagnosi di un medico di Gratz, lo indussero a quel gesto estremo, forse da tempo meditato e solo in parte provocato dalla derisione delle due donne presenti nello scompartimento.(1)
Quando i pochi amici si ritrovarono ammutoliti davanti alla sua bara, solo allora qualcuno ripensò alla sua anima dolce e gentile e ai suoi dipinti pieni di poesia.
 A due mesi dalla sua morte i colleghi allestirono un’esposizione dei suoi quadri nelle sale della “Permanente” (l’attuale Caffè degli Specchi in Piazza dell’Unità) e finalmente fu riconosciuto il suo talento.
A due mesi dalla sua morte i colleghi allestirono un’esposizione dei suoi quadri nelle sale della “Permanente” (l’attuale Caffè degli Specchi in Piazza dell’Unità) e finalmente fu riconosciuto il suo talento.
(1) L’esistenza delle due donne che saltuariamente viaggiavano sulle linee ferroviarie frequentate da Fittke, è riportata in un articolo commemorativo di Livia Veneziani, che assieme al marito Italo Svevo, ospitò spesso l’artista nella loro villa.
Grazie al generoso lascito testamentario della prof.ssa Carlotta Rebecchi, figlia del dott. Giuseppe Piperata che collezionò i quadri di Fittke, 56 dipinti dei 220 eseguiti furono donati ai Civici Musei e nel 2007 collocati stabilmente al Museo Sartorio.
Chiunque si trovasse nelle due stanze a lui dedicate, avvertirà una grande emozione visiva e quasi tattile per le suggestioni che Arturo Fittke seppe imprimere nella sua pittura, anche quando si serviva di semplici cartoni ricoperti in biacca.
Alla prof.ssa Carlotta Rebecchi e alla Sig.ra Fulvia Costantinides, anima mecenate del Museo Sartorio, la nostra riconoscenza per la bellissima raccolta.
Fonte:
Renata da Nova, Arturo Fittke, CRT, 1979
Nella foto la lapide nel Cimitero evangelico donata dagli amici
Sulla triste storia di Arturo ho dedicato un lungo racconto di cui riporto alcuni passaggi (tratti dal libro Sonnenball).
Gli ultimi giorni di Arturo Fittke
Via dello Scoglio, aprile 1910
Dopo aver lavato le poche stoviglie della cena, Arturo le ripose sullo scolapiatti. Aprì un’anta della finestra e guardò se la luna fosse già apparsa sopra le colline di San Giovanni, ma dal bagliore intorno alle nubi più basse si intuiva che doveva ancora alzarsi dagli umidi vapori della valle.
Appoggiò i gomiti sul davanzale e guardò melanconico il viale deserto e privo di suoni. Pensò che sulle fronde degli alberi gli uccelli si fossero stretti negli umili nidi e riscaldandosi con il tepore delle piume, protetti dai pericoli della terra, si fossero abbandonati in sonni tranquilli. Da lassù forse il mondo non appariva loro così ostile.
“Purché alla mia pupilla questa luce che pur guarda la tenebra si spenga e più non sappia questo vano tormento senza via né speranza…” (1)
Ripassando i versi del giovane poeta, Arturo avvertì una gran voglia di pace, di un lento abbandono verso un sonno profondo, una discesa verso un tempo non trascorso, dove il dolore non potesse lasciare la sua impronta e la sofferenza potesse sciogliere le sue fitte trame disperdendole negli spazi infiniti del cielo.
“Tu mi sei cara mille volte, o morte! Verserai il sonno senza risveglio su quest’occhio che sa di non vedere, così che l’oscurità per me sia spenta…”(2)
Le nubi erano divenute dense ed estese e ogni debole raggio di luna scomparve nel buio della notte.
Osservò la misera cucina illuminata da una fioca lampada a petrolio, e sospirò tristemente.
Dietro la tenda a fiori la piccola dispensa era quasi vuota: il cesto di vimini conteneva tre patate grinzose, due carote rinsecchite e delle foglie di sedano ammosciate. Sullo scaffale erano accatastati i barattoli vuoti delle conserve di salsa e marmellata. In una scatola di latta piena d’acqua biancastra, un pezzo di margarina galleggiava tra le mosche affogate.
Sedutosi sulla seggiola di paglia, poggiò i gomiti sul tavolino e si prese la testa fra le mani. Come poteva essersi illuso di raffigurare le nebbie trafitte dai raggi solari, il riflesso del cielo sulle foglie luccicanti di bruma, i riverberi crudi del mezzogiorno o quelli morbidi del tramonto? I suoi dipinti erano solo macchie di colore, immagini deformi di una natura inanimata e come morta.
Quali inutili mete lo avevano indotto a scrutare valli sazie di sole e di pioggia? Quali distorte visioni erano impresse nei suoi cartoni intrisi di biacca? Quanti volti aveva dipinto fissando il loro immobile silenzio? Mai un sorriso nelle loro espressioni, mai un cenno d’amicizia, di complicità, di allegria.
“Tenebre, luce… Ogni ombra fatta dal corpo ombroso minore del lume originale manderà le ombre derivative tinte dal colore della loro origine…” (*)
Gli scritti del Maestro impressi nel suo quaderno di appunti, scorrevano veloci nella sua mente come un rullo in movimento.
“Ogni ombra fatta dai corpi si drizza colla linea del mezzo a un solo punto fatto per intersezione di linee luminose ne mezzo dello spazio“. (*)
Ombra maestra, lume incidente e riflesso… Ombra primitiva, ombra derivativa… Luce, tenebre. Pagine su pagine di ombre, linee apparenti, riflessi di luce. Ogni visione percepita dall’occhio poteva essere sezionata in mille possibili frammenti di lumi e ombre. Qualunque rifrazione sui profili dei corpi doveva essere corretta con delle sovrapposizioni di colore per creare i rilievi e dare profondità alle immagini dipinte.
Corpo, figura, colore… Che complessa struttura per rappresentare una sola infinitesimale parte del mondo e racchiuderla in un piccolo spazio quadrato.
Doveva rinunciare a dipingere una natura così mutevole, sottrarsi alle luci violente e accecanti della sfera solare che penetrava nei suoi occhi malati come un inesorabile globo infuocato.
Luce, tenebre… Ombre primitive, ombre derivative. Luci incidenti su corpi ombrosi… Tenebre riflesse su sofferenze infinite.
Arturo levò le mani dalla fronte accaldata e lasciò penzolare le braccia lungo il corpo, standosene immobile sulla sedia con il mento reclinato sul collo.
All’improvviso un vortice di immagini passò per la sua mente. Cumuli di nubi esplosero come masse in rilievo, si trasformavano in pennellate striscianti per poi svanire in lunghe falde sempre più evanescenti fino a lasciare uno sterminato cielo azzurro.
Ma ecco che delle polveri si sollevano dal suolo intorbidendo la trasparenza dell’aria. Un’ansia crescente gli strinse la gola e un getto di sudore gli imperlò la fronte. Percepiva le gocce scivolare sulla pelle, infilarsi nel colletto e scendere sul petto.
Un alito leggero gli rinfrescò le tempie. L’erba dei prati seguiva il flusso delle folate, le foglie si scompigliavano sui rami con un fruscio sempre più forte finché dei sibili si infiltrarono tra i rami piegandoli con le crescenti raffiche e in poco tempo la furia del vento gonfiò i nembi all’orizzonte che avanzavano saturi d’acqua.
Piccole stille uscirono dalle sue palpebre abbassate, scesero lente sulle gote scavate e caddero sulle ginocchia serrate in una tensione senza tregua. La tempesta annunciata scomparve dal quadro ormai avvolto dalle tenebre.
Un gran gelo pervase il suo corpo. Con immensa fatica si sforzò di muovere le braccia ancora pendenti e le gambe appesantite. Volgendo la testa vide che un raggio di luna rifletteva sul pavimento il telaio della finestra, formando una grande croce. Tremante di freddo, trovò la forza di alzarsi e chiudere l’imposta rimasta socchiusa.
Luce… Tenebre… Un’eterna sequenza senza alcun fine. Tenebre spazzate dalle luci del giorno, dall’implacabile sfera solare che dominava il mondo e accecava i suoi occhi malati.
Con le spalle protese, ingobbito sulla schiena scheletrica, si diresse verso il suo stanzino in punta dei piedi per non far scricchiolare le vecchie assi del corridoio. Da una porta socchiusa sentì il respiro tranquillo dell’anziana madre e il silenzio nella stanza dove dormivano la cognata e la bambina.
Troppo stremato e infreddolito per spogliarsi, si stese vestito sulla branda e si coprì con la coperta.
A volte quella condizione di provvisorietà lo induceva a un sonno rapido e profondo, così poteva riposare per qualche ora senza sogni né pensieri. Ma se la notte fosse stata lunga, allora immaginava di dipingere dei quadri perfetti. Poteva osservare i chiaroscuri delle foglie sovrapposte, il verde più intenso del lato superiore e quello più pallido del lato inferiore, scorgere le loro punte drizzarsi verso l’alto per trarre forza dalla luce del sole e nutrimento dagli umori del cielo. Quando il calore del sole avesse bruciato la loro linfa, si sarebbero flesse verso i rami più bassi, per cercare l’ombra e la frescura vicino a quelli più vecchi, già inclinati per cogliere gli umori della terra e la rugiada dell’erba. Immaginava che l’aria delle valli salisse liberamente aggregandosi in deboli nuvole ora dissolte dal calore del sole, ora condensate dal vento da loro stesse causato.
Era bello essere altrove. Seguire le luci e le ombre sul paesaggio che mutava di colore e densità, come in un quadro animato dove potersi abbandonare e trovare pace.
Ma l’angoscia di quella notte lo avvolgeva con le sue perfide spire e se avesse ceduto al sonno, gli incubi non gli avrebbero dato tregua fino ai chiarori dell’alba.
Il debole riverbero della mezzaluna impallidiva sulle crepe dei muri ingialliti dall’umidità fino a spegnersi del tutto, lasciando la stanza nella penombra diffusa dai lampioni del viale.
In preda a un’incontenibile agitazione, si alzò e appoggiando la coperta sulle spalle, si diresse a tentoni verso il tavolino. Acceso il paralume, rovistò fra la risma di cartoni appoggiati al muro scegliendone due di piccole dimensioni.
In un vaso vuoto versò della biacca di zinco, mezza lamina di colla di pesce e uno spruzzo di scagliola. Aggiungendo poche gocce d’acqua alla volta, miscelò il tutto fino ad ottenere un liquido opaco e sufficientemente denso che poi stese con il pennello piatto sulle superfici dei cartoni. La polvere di gesso avrebbe assorbito i colori mentre l’aggiunta della colla ne assicurava una maggiore trasparenza.
Sentendosi alla fine molto stanco, decise di rimettersi a letto.
Il tepore della coperta e lo sfinimento della sua mente lo accompagnarono dolcemente in un sonno profondo.
(1) – (2) Carlo Michelstaeder “Dialogo della salute e altri dialoghi“, Adelphi, Milano, 1988)
(*) L. da Vinci “Trattato della pittura“
[…]
Seduto accanto al tavolino della sua stanza, Arturo fissava la finestra con sguardo assente.
Era notte, una notte come altre tante notti, senza luci né suoni. Una rotazione di 180 gradi in quarantatremiladuecento secondi se fosse stata una notte di equinozio, ma mancavano esattamente sessanta giorni al solstizio estivo e l’angolo di luce sarebbe stato inferiore di 60 gradi nella rotazione delle 24 ore del giorno, cioè quattordicimilaquattrocento secondi di più oscurità. Ma anche nelle brevi notti del solstizio estivo, il tempo sarebbe trascorso troppo lento, nell’attesa di quel sonno che gli sfuggiva o sfiorava appena i suoi occhi.
Osservò il grosso libro delle Sacre Scritture appoggiato sul tavolo e attirandolo a sé, lo aprì sulla pagina segnata dal nastro rosso.
“Che vantaggio ha l’uomo di tutta la sua fatica e dell’affanno del suo cuore onde si travagliò sotto il sole?
Son pieni di dolore e di cruccio tutti i suoi dì e neppure la notte non riposa col cuore”
Con l’indice della mano destra si asciugò l’occhio inumidito.
“Breve e molesto è il tempo della nostra vita … e non c’è rimedio quando per uno è giunta la fine“.
“Quando per uno è giunta la fine…” ripeté a bassa voce. Sollevò lo sguardo verso la finestra e fissò la croce fra i quattro rettangoli delle lastre. Una luce azzurra filtrò obliquamente sfumandosi sul grigio della parete. “Il passar di un’ombra è la nostra vita…”
Millequattrocentoquaranta ore al solstizio d’estate. “Non c’è rimedio quando per uno è giunta la fine” pensò sospirando.
Appoggiando il libro sulle ginocchia, Arturo passò più volte l’indice sulla riga sottolineata con la matita rossa:
“Saremo poi come non fossimo mai stati“. Saremo poi…, mormorò sottovoce. Lasciando il dito sul foglio, continuò a pensare a quelle parole con gli occhi chiusi.
Le fioche luci della stanza filtravano appena sotto le palpebre e fluttuavano nell’oscurità come piccole stelle.
Se saremo come non fossimo mai stati non potrà esserci che il Nulla, l’Eterno Nulla, anche se quel “Saremo poi” lascerebbe presupporre un futuro a quello che saremo dopo la fine… Un noi diverso da quello che eravamo prima, un noi sconosciuto, che forse non sarebbe nemmeno esistito.
Con il respiro divenuto affannoso, aperse le labbra contratte per cercare un po’ d’aria.
Ridestandosi dopo un tempo indefinito, riprese la lettura, sulla riga ancora segnata dall’indice:
“Si ridurrà in cenere nostro corpo, lo spirito si dissiperà come aria leggera.”
Ecco, non saremo che cenere… Piccole, insignificanti scaglie di cenere, talmente impalpabili da disperdersi nell’aria, mescolate con altre inerti particelle di cenere, sofferenze dissolte e tramutate assieme alla decomposizione del corpo.
“Passerà la nostra vita come una nube … e si scioglierà come nebbia spinta dai raggi del sole.”
Un brivido lo attraversò lungo il dorso e un sussulto fece tremare la sua mano. Una nube di cenere …una nube impregnata da tutto il nostro dolore. Ma i raggi del sole l’avrebbero perforata trasformandola in tanti piccoli cristalli che avrebbero riflesso la loro luce e le polveri di immonda materia, priva di anima e compassione, sarebbero svanite nel riverbero della loro purezza.
Sotto le dita appoggiate a palmo sul libro, Arturo avvertì che la pagina si era inumidita dalle sue lacrime.
Milletrecentonovantadue ore al solstizio d’estate. Non c’era rimedio quando per uno era giunta la fine.
(Versi da Lettere di SanPaolo)
[…]
Scompartimento della linea ferroviaria Gratz – Divaccia. 24 aprile 1910
Uno sghignazzo sovrapposto ai rumori del treno in corsa, lo fece trasalire. Nella panca di fianco alla sua, una donna parlottava con la sua vicina che ascoltandola, emetteva dei risolini intervallati da sghignazzi più sonori. A tratti però si fermava e lo guardava con faccia ilare come se il suo parlare fosse esilarante anche per lei, seppure non quanto lo fosse per l’amica.
Arturo non si era accorto della loro presenza. Forse stava sonnecchiando quando erano salite, o avevano parlato sottovoce. Ma ora qualche imperscrutabile motivo da lui indotto, aveva destato il loro sollazzo. Assalito da un’incontenibile angoscia, chiuse con un colpo secco il suo libro appoggiandolo rovesciato sul sedile. Ciò sembrò divertire le due sciocche comari che esplosero in un’ilarità senza ritegno.
L’enorme peso della sua sofferenza repressa stava per esplodere davanti gli sguardi di quelle miserabili donnine che non smettevano di osservarlo. Le loro bocche volgari si aprivano a dismisura lasciando intravedere le lunghe lingue sprezzanti ma ancora troppo corte per soffocare quelle ugole malvagie.
Ma presto il loro urlo avrebbe strozzato quelle gole avvezze alla maldicenza, la sconvolgente visione riuscirà a violentare i loro occhi indiscreti turbando per sempre le loro anime ingenerose. L’orrore di quel che vedranno non sarà mai cancellato dalle loro povere vite, inconsapevoli provocatrici del suo coraggio disperato.
Annichilito da quanto ormai stava per accadere, Arturo non si alzò.
Chinandosi appena, prese la valigia di legno e l’appoggiò sulle ginocchia, roteando l’apertura verso il finestrino. La mano tremante strinse la canna d’acciaio. Era rigida e fredda.
Guardò la lastra del finestrino e vide riflessi i suoi occhi infossati sotto le tempie madide e bianche.
Un assoluto silenzio avvolse per un attimo lo scompartimento prima dell’esplosione.
Gabriella Amstici



 La presentazione al Circolo della Stampa di tutta la serie di diapositive accompagnate dalla musica delle Quattro stagioni di Vivaldi emozionò moltissimo il pubblico che acquistò con piacere quel libro dedicato alla nostra amata città.
La presentazione al Circolo della Stampa di tutta la serie di diapositive accompagnate dalla musica delle Quattro stagioni di Vivaldi emozionò moltissimo il pubblico che acquistò con piacere quel libro dedicato alla nostra amata città.